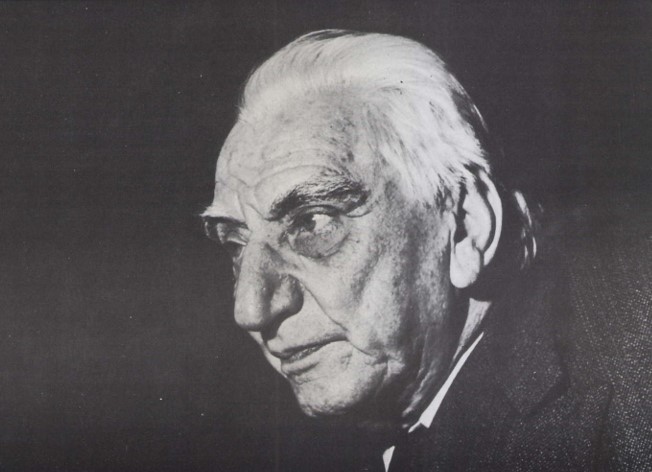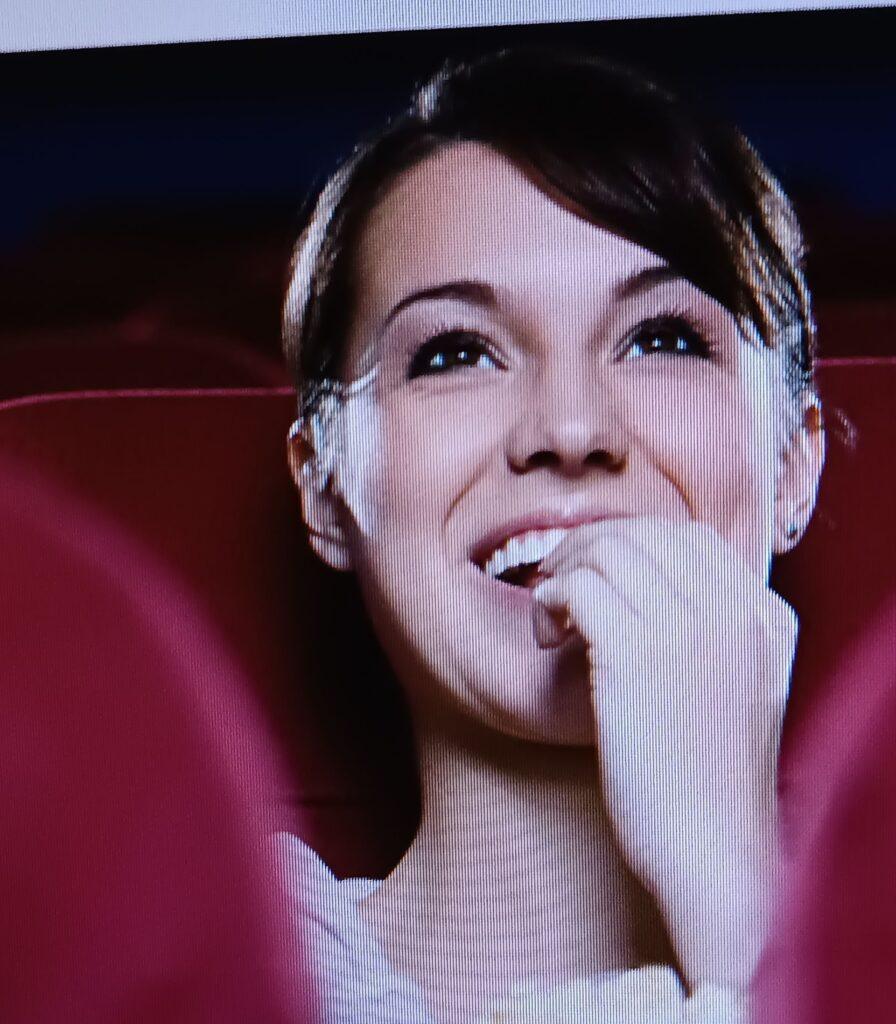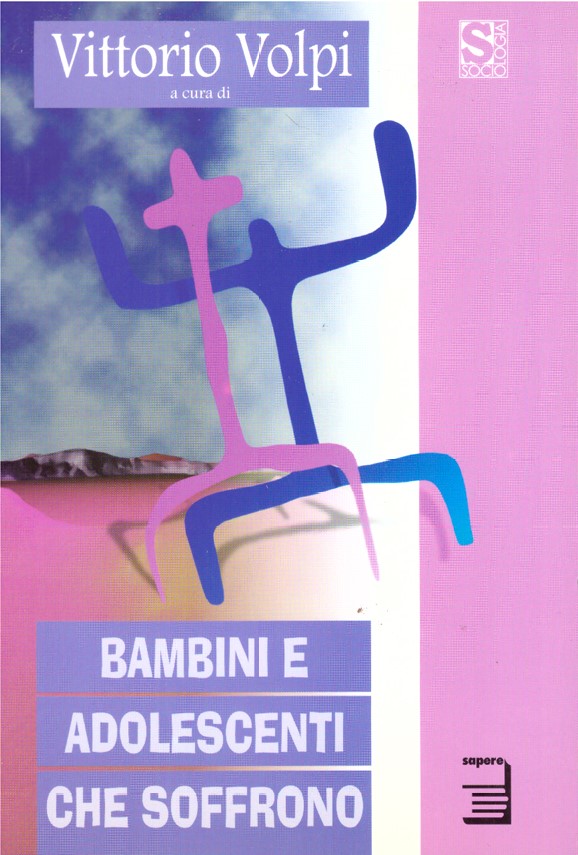Propongo delle interviste a Cesare Musatti, ritenuto spesso il “padre” della psicanalisi in Italia. Le due interviste, la prima a cura di Vittorio Volpi sul “Potere dello psicanalista” con un suo commento particolarmente interessante poiché permette una lettura dell’intervista a Musatti.
La seconda, a distanza di quattro anni a cura di Maurizio Molteni ed Eva Lucchesi Tagliabue, sul ruolo dello psicologo in un’epoca in cui nasceva l’Albo degli Psicologi, con tutte le polemiche e le discussioni ad esso collegate.
Ecco il materiale pubblicato sulla rivista Analisi Psicologica.
Analisi Psicologica – Anno IX – N. 4 – Aprile 1986
L’AUTORITÀ DELL’EDUCATORE – ANALISTA di Vittorio Volpi
Ho effettuato questa intervista nel marzo del 1982, e ho aspettato, per pubblicarla, di avere il contesto più adatto, come quello attuale di risvegliato interesse per la professione di psicanalista. Finalmente, grazie alla ricerca scientifica condotta in oltre un decennio presso il nostro Centro, questa professione si delinea con la necessaria chiarezza, per quello che è, vale a dire come lavoro educativo. L’intervista al più antico – non mi sento di chiamarlo “vecchio” perché vecchio non è ancora. anzi – degli psicoanalisti viventi, con il suo frasario storico, con l’impronta incancellabile di una lunga lunghissima pratica psicanalitica, conferma tutto ciò, corrispondente in modo sorprendente con i risultati cui siamo pervenuti.
Riletto qualche giorno fa dallo stesso intervistato, insieme con i colleghi Eva Lucchesi Tagliabue e Maurizio Molteni, il testo non ha subito particolari modifiche, perchè quello che in esso si afferma è solo un pochino travestito (non travisato: sarebbe impossibile) dal linguaggio teorico, e ciò che affiora, che parla, è l’esperienza, quella solida base professionale che solo la pratica, esercitata con intelligenza, può dare. Merita perciò qualche riga di commento esplicativo.
1. Gross e Benussi. Come è noto, non solo il primo, ma anche il secondo é morto suicida (cianuro. Nel caffè). Che maestri, dunque, per uno psicanalista. Come ha potuto diventare allora così bravo? Non c’è altra possibilità: nonostante Gross e Benussi fossero depressi gravi, hanno potuto essere ottimi maestri di psicanalisi. La loro personalità sofferente, la loro esperienza diretta di problemi psicologici è stata il loro vero patrimonio didattico. E ciò risponde a quanti si stupiscono che alla professione psicanalitica si accostino proprio le persone più ricche (è il caso di dirlo) di problemi. Ma c’è anche un altro risvolto, tipico di ogni esperienza pionieristica, e riguarda i rischi del mestiere, tanto più grandi quanto più ignorati. Un utente depresso induce la propria depressione nell’analista. Non a caso Musatti dichiara di rifiutare clienti psicotici: ha avuto senz’altro degli ottimi maestri. Infatti, nella nostra professione il coinvolgimento emotivo con il cliente è tale che, senza una professionalità, una preparazione specifica per quell’ordine di stati emotivi che l’utente esprime„ l’analista perde il proprio equilibrio. Ciò che constatiamo regolarmente nella nostra Scuola di Psicanalisi, dove gli allievi, all’inizio, necessitano, più che di supervisione, di una vera e propria assistenza psicanalitica, anche se circoscritta ogni volta a quel determinato caso che hanno in carico.
2. La psicanalisi non è una terapia (e meno ancora una “psicoterapia”) ma un processo educativo. Prevede infatti il coinvolgimento, tipico dell’educatore con l’utente, ma può permettere che questo coinvolgimento arrivi molto in profondità, ovviamente con le dovute precauzioni, onde evitare le spiacevoli conseguenze di cui al punto 1. Naturale pertanto che la psicanalisi sia uno strumento prezioso per chiunque (genitore, insegnante), abbia a che fare con soggetti in età evolutiva.
3.Il transfert. Significa “trasferimento” nel rapporto con l’analista della modalità di rapporto primario, di natura simbiotica, con il genitore omologo. Ovvio che il transfert non possa riferirsi al rapporto primario: se si fa uso del rapporto con il genitore omologo, non c’è motivo di “trasferimenti” di sorta in altri rapporti. E anzi proprio sul rifiuto, da parte del figlio, di valersi del rapporto primario con il genitore, che lavora l’analista: riconducendo “per mano” il cliente al genitore, del quale rivela al figlio tutto l’amore, la dedizione. Per questo l’analista “deve” farsi pagare. Perché non sorga il sospetta che voglia proporsi come sostituto del rapporto primario, in cui non si scambia di certo denaro.
4. Il potere della psicanalisi. Sorvoliamo sul delirio di onnipotenza, con cui gli analisti compensano la propria profonda consapevolezza di contare, per i propri clienti, meno di niente. Tanto è vero che, quando non serviamo più, veniamo scaricati senza tanti complimenti e senza nessuna riconoscenza (perciò dobbiamo farci pagare…). E sorvoliamo anche sui “lauti” guadagni dello psicanalista, visto che lo stesso Musatti guadagnava così “tanto” che ha dovuto continuare tutta la vita a fare il doppio lavoro, come professore universitario. E anche l’analisi storica del volto del potere, è quanto meno sbrigativa, come se Giulio Cesare, i Bizantini, Teodorico, Carlo Magno, Napoleone o la regina Vittoria non avessero usato contemporaneamente denaro, esercito e politica per i loro fini di potenza. Il “potere” qui non è certo quello di chi esercita l’estorsione (delitto del quale si sono resi di gran lunga colpevoli da Giulio Cesare, a Carlo Magno, alla regina Vittoria, e in scala un po’ più grande). Ma è quello di “chi può”. Ma può che cosa? Ebbene: prendersi le proprie responsabilità. Si tratta perciò non di potere (=esercizio della facoltà decisionale in nome di altri senza assunzione delle relative responsabilità, come per esempio quando durante la guerra si decide la morte altrui e non solo non si è ritenuti responsabili, ma anzi ti danno la medaglia) bensì di autorità (= capacità di assumersi tutte le proprie responsabilità). Ancora una volta siamo di fronte all’equivoca denominazione di “autorità” attribuita ai “pubblici poteri” (che semmai sono “autoritari”). Che ci sia un uso della psicologia, da parte del potere, non ci sono dubbi. Basti pensare all’uso della propaganda, tipico strumento psicologico. Ma lo psicanalista, per poter lavorare, deve per forza essere capace di autorità. Il potere è infatti prerogativa dei disperati, degli insicuri, di coloro che, per le ragioni più diverse, non hanno imparato a usare la propria autorità. Se riuscissero, sarebbero indubbiamente molto più felici. Quanto infine a sedurre le fanciulle, beh, credo sia inutile spiegare perché quelle che si rivolgono allo psicanalista abbiano, nelle loro certezze, qualcosa di meglio di un antico psicanalista (il quale, di tanto in tanto, si guarderà pure nello specchio). Semmai, può essere il contrario. A volte capitano persone cosi sradicate che si attaccherebbero a chiunque, tanto si sentono svalorizzate. Persino allo psicanalista… Si tratta, allora, per quest’ultimo, di stare attento a non agire i bisogni dell’utente. Anche perché andrebbe incontro ad amare delusioni (vedasi ancora il punto 1).
5. Il potere sul paziente. La favola che lo psicanalista “legge” nell’inconscio del paziente quello che lo stesso paziente non riesce a leggervi è pura leggenda. Intanto l’inconscio non esiste: si è chiamata cosi solo la componente emotiva, sentimentale, della personalità; “inconscia” essa poteva essere considerata solo dagli accoliti di Francesco Giuseppe, che sciamavano in divisa, per l’Austria-Ungheria dei tempi di Freud, “nella vigna a far da pali”. Solo a un sottufficiale dell’esercito prussiano poteva del resto apparire come una sentina di “desideri immondi’ la sede di ciò che è più nobile nell’uomo: la pietà, l’amore, la tenerezza, la gioia, la commozione. Tutte doti assai poco adatte a chi – per professione! – deve imparare a uccidere, torturare, saccheggiare, distruggere. Tutte “debolezze da donnicciole”. E infine, bella forza sarebbe “tenere in pugno” un povero diavolo che viene da te perché è pieno di problemi, perché ti chiede la sua consulenza per districarsi. Bel potere sarebbe davvero, da Maramaldo. No. l nostri clienti non sono tanto pazzi da scegliersi per analista un farabutto. Se uno è tanto scaltro da provarcisi, a imbrogliarli, come si è visto sono proprio loro che lo mandano in galera. Credo piuttosto che l’analogia con l’attore sia invece la sola calzante. Non fu il sociologo Alberoni a definire, nella sua tesi di laurea (dove, ammettono anche i suoi detrattori, ha detto qualcosa di valido), la gente di teatro, gli attori una “élite senza potere”?

IL “POTERE” DELLO PSICOANALISTA
intervista a Cesare Musatti a cura di Vittorio Volpi
Cesare Musatti, autore in Italia delle prime pubblicazioni organiche sulla psicoanalisi oltre che di numerose altre su temi connessi alla psicologia, è a tutt’oggi uno degli psicoanalisti italiani più importanti.
Domanda – È stato il primo?
R. — Il primo è stato il triestino Weiss analizzato da un allievo di Freud a Vienna durante la prima guerra mondiale.
La mia analisi l’ho fatta con un altro triestino formatosi a Graz, in Austria e venuto a Padova, dopo la guerra come Professore di Psicologia all’Università, dove mi stavo laureando in Filosofia: il Professor Benussi.
Domanda — Analizzato?
— Si, da Gross, che però era completamente matto, figlio di un antropologo criminale famoso in Austria, era stato analizzato prima da Freud, e poi da Jung il quale in una lettera a Freud fece una diagnosi di “dementia praecox”. Gross andò in carcere per aver ucciso un uomo, e lì si suicidò. Pensi, il figlio dell’antropologo criminale che va in carcere per omicidio. E poi si suicida. Come psicanalista da cui derivo, non è che sia molto raccomandabile.
Domanda — Perché?
— Perchè fece l’analisi a Benussi…
Domanda — Che tipo di analisi?
— Allora per analisi, si potevano intendere anche trattamenti per pochi mesi.
Domanda — Con sedute più lunghe?
— Il dogma della seduta di cinquanta minuti è venuto dopo. La mia analisi con Benussi à durata circa due anni. Non pagata, perché ero il suo assistente: mi chiamava, e: “facciamo un po’ di analisi» diceva ‘venga qui e mi racconti i sogni…”. Era un’analisi senza il setting, casalinga…
Domanda — Ma con il prestigio, l’autorità del professore…
— Certo, ma fin troppo, Perchè non c’era separazione del rapporto di analisi con il resto della nostra vita. Ero il suo figlioccio… Come se il padre facesse l’analisi al figlio.
Domanda — il rapporto ideale…
— Il transfert con il proprio padre non é possibile, perchè bisogna che sia un padre acquisito. La mia non è stata una buona analisi personale.
Domanda — Lei non è un «buon psicanalista” allora…?
— Mi sono fatto da me, come tutti i primi. Ferenczi per esempio fece tre settimane di analisi con Freud. Le sedute duravano tutto il giorno a spasso per Vienna. La psicanalisi è nata cosi; le regole sono venute dopo, analogamente a quanto è avvenuto per il Cristianesimo.
Domanda — Il Cristianesimo?
— Gesù, se c’è stato, ha agito, limitatamente a quel piccolo mondo ebraico attorno a Gerusalemme. Ma è San Paolo che organizzandone i contenuti ha universalizzato il Cristianesimo. Le eresie sono infatti la naturale conseguenza di tutto il movimento teoretico, con cui si è creato un fondamento dottrinale. In un primo tempo, per esempio, i seguaci di Ario erano più numerosi di quelli che poi sono divenuti Cattolici.
Domanda — Ma la Psicoanalisi?
— Come per il Cristianesimo, anche per la psicoanalisi si può parlare di una fondazione dottrinale., dell’organizzazione dei suoi contenuti per la sua diffusione, per la sua affermazione in termini di potere.
Domanda — Di potere?
— Nel Medioevo il potere era delle armi: diventava capo chi battagliava meglio. Poi è venuto il periodo mercantile, in cui il denaro era lo strumento del potere. Quindi lo è divenuto la capacità di manovrare masse di uomini, cioè la politica. Ma oggi il potere psicologico è il massimo del potere.
Domanda — Il massimo?
— Un individuo il quale dice: io capisco tutti gli uomini. E che razza di potere è: non è potere, questo?
Domanda —Se capisce, è meraviglioso. Ma appunto: che razza di potere è?
— È il potere di chi afferma di riuscire attraverso l’impostazione analitica, a vedere dentro un individuo quello che l’individuo stesso non vede dentro di sè.
Domanda — Ma è vero poi?
— É vero si. Uno psicanalista arrivato ha una posizione economica buona…
Domanda — Non eccezionale…
— … però non eccezionale. Appunto. Non è certo quello che la gente crede. Ma in compenso ha nel rapporto analitico, una determinata soddisfazione, ha il senso, proprio per come il paziente vive una condizione di transfert nei confronti dell’analista, di esercitare sul paziente, sugli individui che ricorrono a lui, un potere che non può essere esercitato in nessun’ altra maniera… È il controtransfert.
Domanda — Cioè un sentimento di potere come lei dice: non una realtà.
— Ci sono migliaia di individui che si iscrivono nelle facoltà di Roma e di Padova, credendo di diventare psicologi e da dove invece escono dei disgraziati, che poi non sanno assolutamente cosa fare, perchè la professione di psicologo non esiste. Poiché l’unica forma di attività professionale consistente per un laureato in psicologia è la psicoterapia (che però non sa fare) in buona parte gli studenti desiderano diventare psicoanalisti. E la psicanalisi non è altro che una forma particolare di psicoterapia.
Domanda — Bisogna anche lavorare…
— Certo. Bisogna lavorare ma anche saper lavorare, mentre chi esce dalla facoltà di Psicologia ha la presunzione di voler esercitare un potere, come pensa lo eserciti io. È questo a spingerli verso la facoltà di psicologia. Un tempo buona parte di queste persone avrebbero voluto diventare come Agnelli. Oggi vogliono diventare come me: mi mettono sullo stesso piano di Agnelli…
Domanda — Come professore universitario di ruolo, avrà avuto un potere reale. Ma come psicanalista lei è un artista, non un uomo di potere .
— Quando parlo di potere non vorrei essere frainteso. Ma sono un uomo di potere, non perché io abbia delle masse di uomini che mi seguono, ma perché un certo dominio lo psicanalista lo esercita. Ci sono delle ragazze di vent’anni che mi vorrebbero abbracciare. Alla mia età… Se io riesco a fare in modo che una ragazza di vent’anni desideri abbracciarmi, lei non lo chiama potere questo?
Domanda — Qui con lei si sta molto bene. Non le dico certo una cosa nuova. Se considera il piacere che io provo a stare adesso con lei, siamo di fronte a una forma di potere abbastanza singolare.
— E va bene: io riesco a far sì che la gente stia bene con me. E le par poco?
Domanda — Tutt’altro: è il massimo. Non del potere…
— Ma è potere, Lei non vuol capire… Le dà fastidio la parola potere? Ma perchè lei ha in mente il potere, sempre, diciamo così, come prevaricazione. Però questa posizione di superiorità esiste: l’analista ha nei confronti del paziente il senso di averlo in pugno.
Domanda — Di averlo in pugno?
— Ce l’ha in pugno, non per utilizzarlo, ma ce l’ha; ce l’ha in braccio. Dico sempre: quando accogliamo un paziente, è come se ci dessero in mano un bambino, come se avessimo un bambino da tirar su… Il mio potere consiste nella capacità di rivivere determinati elementi della sua vita. Come se ci fossi dentro. Io ci sono dentro; ci sono come un attore che si cala nel personaggio. Il mio è il potere dell’attore.
Analisi Psicologica – Anno IX – N. 8- Agosto 1986
A CHE COSA SERVONO I LAUREATI IN PSICOLOGIA?
Intervista a cura di Eva Lucchesi Tagliabue e Maurizio Molteni
Il dibattito sull’opportunità o meno dell’Albo degli Psicologi risente molto dell’utilizzo, spesso con significati differenti, del termine “psicologo”. Abbiamo chiesto al Professor Cesare Musatti di aiutarci a fare un po’ di chiarezza. Come è noto gli interventi del Professor Musatti sul tema, sono molteplici e rispecchiati nelle numerose pubblicazioni di cui riportiamo a parte l’elenco cronologico.
Domanda — C’è confusione…
Si, c’è molta confusione nei termini perchè con gli anni sono proliferate le occasioni di impiego di strumenti di carattere psicologico, e ogni volta non ci si è troppo curati di concordare con gli altri una terminologia valida per tutti e che avrebbe semplificato le cose.
Domanda — Esiste lo Psicologo?
Certo che esiste, come attività accademica, come retaggio della filosofia dapprima e della Psicologia sperimentale a fondo fisiologico poi. Il Professor Mosso di Torino fu il primo in Italia.
Domanda — Come professione?
Come libera professione non ha molto senso. Anche quando si parla di psicologo del lavoro, psicologo dello sport, psicodiagnosta, siamo di fronte sempre a persone che intervengono in una realtà per esaminarla, ai fini di modificarla. Siamo di fronte cioè a degli “psicoterapeuti”.
Domanda — Ma lei è stato psicologo del lavoro…
Io ho fatto lo psicologo di fabbrica ma nel 1948, in piena ricostruzione, nei periodi di grande benessere qualche cosa da fare si trova, perchè l’industria si può permettere di avere anche lo psicologo. Però adesso in fabbrica non serve più a nulla. Ci sarebbe anche da fare, ma siccome gli interessi economici prevalgono sull’interesse per il benessere degli operai, gli stessi operai preferiscono più soldi in busta paga, e magari l’assistenza psicologica se la cercano fuori.
Domanda — Lei cosa faceva?
Ho fatto alcuni lavori sul cottimo. I tecnici non vedevano i problemi dell’operaio nel rapporto con il lavoro.
Domanda — Cioè?
Senza una mentalità psicologica non si riesce a comprendere come il lavoro per ogni essere umano viene organizzato in un tutto unico. L’operaio, essendo un essere umano, tende a infondere una certa armonia in quello che fa.
Domanda — E la parcellizzazione?
La parcellizzazione, il principio base del Taylorismo, è proprio l’antitesi di questo. Non si può frazionare un’attività in tanti piccoli segmenti. Non è vero che una operazione sia la somma di questi piccoli atti, di una serie di contrazioni muscolari. Sarebbe come se si considerasse la musica come la somma delle note. Mentre invece è il frutto di una sintesi dove le varie note, e nel lavoro i vari atti, seguono una legge che produce il risultato finale armonico, ben diverso dalla semplice somma delle parti.
Domanda — È il principio delle “isole”?
Certo, quelle realizzate alla Volvo svedese, e arrivate da noi 30 anni dopo. Allora come psicologo all’Olivetti di Ivrea, avevo fatto uno studio in questa direzione. Ma il mio lavoro gli è tornato utile, lo hanno ripescato, soltanto quando gli operai, che sulla catena di montaggio impazzivano, perdevano la virilità, si rifiutarono e fecero crollare il vecchio sistema.
Domanda — Che rendeva di più…
In termini immediati, forse. Ma come costo globale, come spesa sociale per i disturbi che provocava e i danni alla produzione stessa (per apparecchi difettosi) i conti non tornavano, tanto è vero che è entrato in crisi irreversibile.
Domanda —Ma allora lo psicologo serve…
Allora sì. Se fossimo stati trenta almeno o cinquanta sarebbe stato utile perché l’industria italiana se ne sarebbe potuta giovare. Ma ero solo in un ambiente non ancora preparato.
Domanda — E oggi?
Oggi quegli psicologi del lavoro non servono più. Ci sono gli esperti di tempi e metodi, che fanno quello che si chiede loro molto meglio di uno psicologo.
Domanda — Ma l’aspetto umano?
Anche un bravo direttore del personale se ha un rapporto circoscritto a un numero limitato di dipendenti li può conoscere tutti, e se è intelligente riesce a fare un’attività di assistenza psicologica meglio di qualsiasi altro. Infatti dipende da lui l’organizzazione del personale, e può intervenire con poteri che lo psicologo non avrebbe mai.
Domanda — Senza laurea in Psicologia?
Nessuna laurea può far nascere una vocazione psicologica. La laurea in Psicologia poi assomiglia a quella che una volta era la laurea in Cultura. Il Professor Ossicini si dà molto da fare per migliorare queste situazioni, per qualificare meglio i laureati che escono completamente sprovveduti da una Facoltà inutile, capace solo di alimentare illusioni. Ma egli fa quello che può. È sempre stato all’opposizione, vuol dire cioè che non ha mai governato. Le sue iniziative politiche, come quella dell’Albo, sono perciò necessariamente il frutto di compromessi con chi detiene il potere. Non credo che potrebbe fare di più.
Domanda — La Legge è alla Camera…
Infatti. La Legge non è più al Senato, e il Professor Ossicini non c’entra più. E stato suo merito sollevare il problema. È merito suo se voi oggi siete qui e volete capire di più.
Domanda —E sempre stato così?
La Società di Psicologia cui mi iscrissi dopo la laurea era composta da una ventina di persone. Erano Professori universitari: 3 ordinari, 2 o 3 incaricati, qualche libero docente e gli assistenti. Ci conoscevamo tutti. Ogni tanto facevamo dei congressini. Tengo le fotografie. Ce n’è una fatta davanti all’Istituto di Psicologia di Roma. Con noi c’è anche uno dei tecnici di laboratorio, quei tecnici tutto fare che preparavano le apparecchiature psicometriche in uso allora; questo per dire il clima di familiarità che c’era.
Domanda — E adesso?
Mi suscita commozione l’interesse per la psicologia nei giovani di oggi, perchè agli inizi noi eravamo degli isolati. Nell’ambiente filosofico ci dicevano “ma voi siete dei fisiologi”. In quello medico invece ci consideravano dei filosofi. Adesso è tutto cambiato, ma non vedo gli ideali di ricerca di un tempo. Mi sembra che il successo della Facoltà sia dovuto alla ricerca di molti di un modo ritenuto facile, tra l’altro, per esercitare del potere sulla vita altrui.
Domanda — Sarà forse per i nevrotici…
Un genere particolare persegue il potere sui propri simili, quello con caratteri paranoidi.
Domanda — Ma la gente se ne accorge!
Questo lo crede lei. C’è molta gente che di fronte a chi dichiara semplicemente di essere studente di psicologia si apre a confidargli tutto di sé.
Domanda — A noi capita piuttosto di incontrare una sana diffidenza…
Sarà vero, ma a me capita ancora che persino l’autista sul taxi, appena sa che insegnavo psicologia, mi racconti i fatti suoi e alla fine non voglia essere pagato, mettendomi in una posizione imbarazzante.
Domanda — Se fossimo taxisti neanche noi la faremmo pagare, perchè è un piacere stare con lei. E poi è difficile non riconoscerla…
Può darsi che sia così. Ma rimane il fatto comunque che chi esce dalla Facoltà ha solo la possibilità di insegnare. Quindi non esiste una professione di Psicologo e in questo senso l’Università potrebbe fare qualcosa per informare gli studenti sulla reale consistenza delle prospettive di lavoro.
Domanda — C’è la psicanalisi…
Ma lo psicanalista non si può improvvisare certo con un corso di sei mesi. Egli può lavorare bene solo se è una persona matura. Gli ci vuole l’esperienza, quella della vita prima di tutto, e quella professionale. Entrambe si acquisiscono solo con gli anni, oltre che con un impegno tale, da essere accettato solo da chi è veramente appassionato a questo lavoro.
Per approfondimenti sull’opera di Cesare Musatti consigliamo di visitare il sito dell’Archivio Storico della Psicologia Italiana – ASPI ->QUI